
La conflittualità tra fratelli di per sé non è negativa, anzi rientra in una normale esperienza evolutiva. Semmai, ciò che potrebbe destare preoccupazione è il fatto che la conflittualità/aggressività venga espressa in modo poco opportuno, oppure viene negata, come se fosse qualcosa da reprimere, quindi proibita. In realtà, per un bambino è di fondamentale importanza confrontarsi con la conflittualità e l’aggressività, per esempio quando si tratta di imparare a riconoscere e quindi difendere i propri spazi, i propri bisogni, le proprie idee, ecc. Al riguardo diventa determinante il ruolo dei genitori nel far si che la famiglia possa diventare una palestra dove i bambini imparano si, a condividere i propri spazi, ma anche a far valere i propri diritti, a essere generosi e anche egoisti, perché entrambi gli atteggiamenti appartengono in modo naturale all’essere umano e sono funzionali alla sopravvivenza. La prima cosa è accettarli. Tutte le emozioni sono funzionali nella vita e non vanno negate. Dall’etologia (studio del comportamento degli animali) sappiamo che i cuccioli giocano lottando ai fini dell’abreazione dell’aggressività. In altre parole sanno bene che nella loro vita, devono fare i conti con un compito che li accompagnerà per tutta la vita : conciliare l’istinto alla socializzazione con quello dell’aggressività.
Alcune regole utili per i genitori.
Evitare i paragoni
“Hai visto com’è stato bravo tuo fratello?”, “Sei sempre il solito prepotente! Guarda tua sorella invece come….”. Queste e altre sono frasi, non soltanto sono inutili e feriscono il bambino, ma minacciano la sua autostima e integrità psico-fisica, oltre ad alimentare la competizione tra i fratelli. E’ preferibile parlare con loro separatamente esprimendogli il proprio disappunto. Questo potrebbe essere un buon modo per dare a ciascuno la giusta attenzione, che spesso è il vero oggetto del contendere.
Essere arbitri neutri
E’ difficile rimanere neutri di fronte un litigio tra fratelli, ma bisogna sforzarsi ad esserlo. Bisogna mantenersi “esterni” lasciandoli litigare, almeno fino a quando non passano all’aggressività più fisica e ostile dove rischiano di farsi male seriamente.. Se poi i bambini sono piccoli, ancora in età prescolare e uno dei due è molto aggressivo, è consigliabile vigilare per impedire che il più debole venga picchiato. A questa età i bambini non hanno ancora la consapevolezza che i loro gesti possano avere conseguenze.
Chi l’ha detto che i bambini devono essere alleati a “tutti i costi”?
Più esortiamo i bambini a “diventare amici”, a condividere i giochi, a fare tante cose insieme, (nella speranza che così litighino di meno…) più li metteremo in difficoltà, riproponendo proprio le situazioni che innescano i conflitti. Quando vorranno giocare insieme, i bambini lo decideranno da soli. Inoltre, credere che debbano andare d’accordo a tutti i costi è un vero e proprio pregiudizio che nasce da un’ignoranza psichica e culturale. Ricordatevi che voi non avete scelto di avere un fratello o una sorella, un cugino o una zia, al massimo potete scegliere i vostri amici!
Non cercate un colpevole
Se intervenite per interrompere un litigio tra fratelli cercate di evitare assolutamente di mettervi nel ruolo del giudice che sentenzia il colpevole e l’innocente. Tale atteggiamento (tra i più sbagliati e financo pericolosi) alimenterà maggiormente nel tempo la rivalità tra i fratelli. Limitatevi a far cessare lo scontro se lo reputate eccessivo e pericoloso per la loro incolumità fisica.
L’importanza degli spazi autonomi
Tra i più frequenti motivi di litigio, troviamo l’invasione degli spazi personali, ad esempio la televisione, il videogioco, il bagno, l’uso della scrivania, dei vestiti, ecc. E’ importante quindi che ognuno di loro abbia il proprio abbigliamento, un suo spazio fisico e temporale e stabilire con chiarezza ciò che va condiviso e con quali modalità e regole.
Le emozioni vanno espresse e non soffocate
Questa importantissima regola vale tanto per i bambini quanto per gli adulti. Bisogna imparare a vedere i litigi come un’opportunità per incanalare la rabbia e l’aggressività che inevitabilmente si accumula nel corso dei giorni. Piuttosto ciò che sarebbe più utile è aiutare i bambini a poter esprimere la loro rabbia senza ricorrere necessariamente alle mani. Ricordatevi che l’aggressività è innata, quindi è una funzione psichica naturale.
E se la situazione degenera? Se ad un certo punto litigio tra fratelli degenera in urla e botte, allora la cosa migliore da fare è quella di dividerli senza incalzare verbalmente o peggio con le mani, in quanto gli arriverebbe un messaggio paradossale, cosiddetto schizofrenogenico. Inoltre perdereste in credibilità e rispetto. D’altronde come potete essere credibili se voi ricorrete alle botte per porre termine ad un litigio dove loro usano le botte? Inoltre, se volete far passare il messaggio che le botte sono vietate e riprovevoli, come pensate di poterci riuscire se poi le usate anche voi? Non vi sembra paradossale?
Stabilire e formulare regole chiare e farle rispettare
È fondamentale stabilire regole che riguardano la gestione degli spazi in casa, degli oggetti, degli orari dei pasti, della condivisione, e così via. Ciò che è importante, non è tanto preoccuparsi se una regola è sbagliata o meno, quanto piuttosto che sia chiara, sensata e farla rispettare. Così ad esempio, si può stabilire che: è vietato picchiarsi; insultare e offendere; rompere gli oggetti; fare scenate in luoghi pubblici; ecc
Dott. Marco Franceschini.




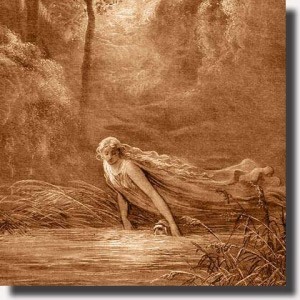


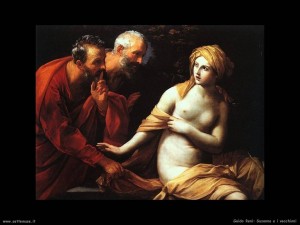

 subito, anzi, è ricordo del torto subito, trasformato all’interno di un contesto più vasto, ovvero, come ha detto C. G. Jung, il sale dell’amarezza trasformato nel sale della saggezza. Una saggezza , Sofia, che, una volta ancora, rappresenta un contributo del femminile al maschile, in grado di fornire quel contesto più vasto che la volontà da sola non sa raggiungere. La saggezza di cui parlo è quell’unione di amore e necessità, dove finalmente il sentimento può riversarsi liberamente nel nostro destino, riconciliandoci con ciò che ci è accaduto. Così come la fiducia conteneva il seme del tradimento, il tradimento contiene in sé il seme del perdono.
subito, anzi, è ricordo del torto subito, trasformato all’interno di un contesto più vasto, ovvero, come ha detto C. G. Jung, il sale dell’amarezza trasformato nel sale della saggezza. Una saggezza , Sofia, che, una volta ancora, rappresenta un contributo del femminile al maschile, in grado di fornire quel contesto più vasto che la volontà da sola non sa raggiungere. La saggezza di cui parlo è quell’unione di amore e necessità, dove finalmente il sentimento può riversarsi liberamente nel nostro destino, riconciliandoci con ciò che ci è accaduto. Così come la fiducia conteneva il seme del tradimento, il tradimento contiene in sé il seme del perdono.